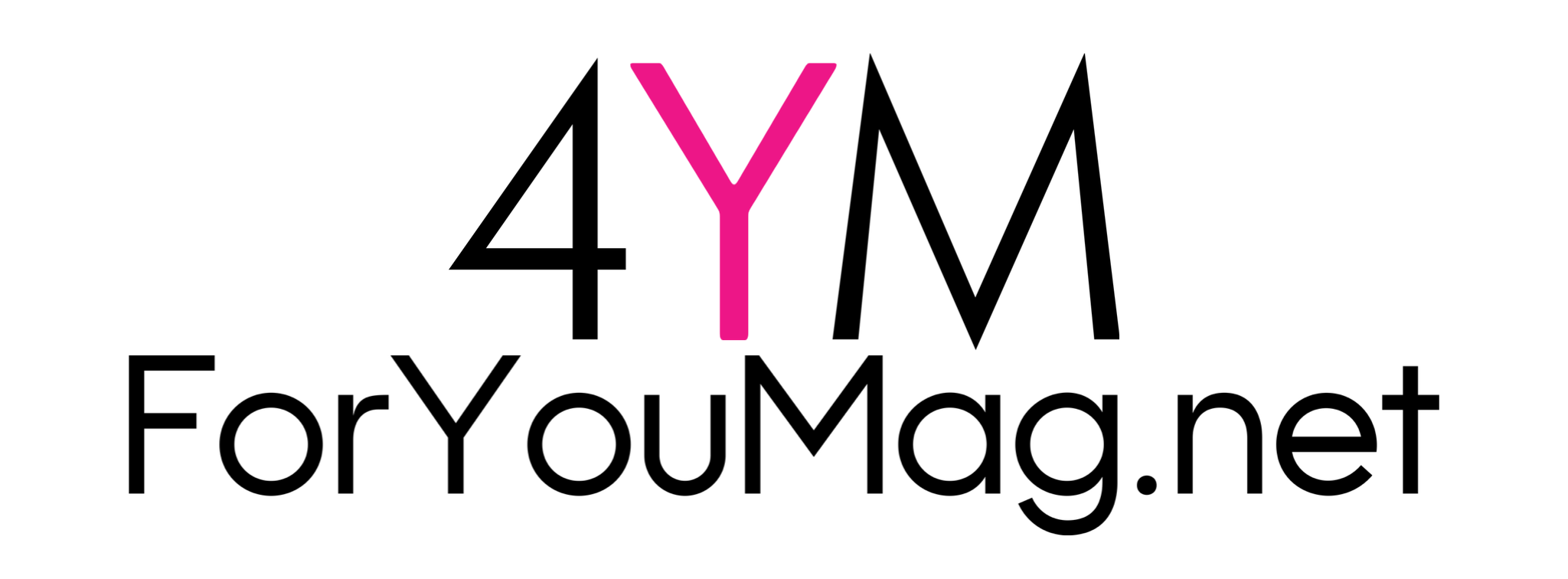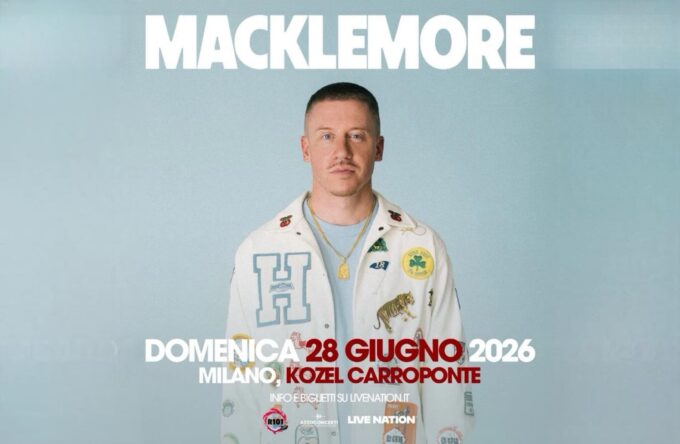Nell’intreccio stratigrafico che è la città di Roma, ogni palmo di terra cela il potenziale di riscrivere la storia. Lo conferma l’eccezionale rinvenimento avvenuto nel cuore della capitale, nel settore orientale del Foro di Traiano, dove una testa marmorea colossale è emersa durante gli scavi condotti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali lungo via Alessandrina. Il contesto archeologico è quello d’eccellenza: l’area monumentale dell’ultimo e più grandioso dei fori imperiali, concepito da Apollodoro di Damasco per celebrare la vittoria di Traiano sui Daci e realizzato tra il 107 e il 113 d.C.
La testa, un frammento scultoreo di dimensioni monumentali, si configura come un eccezionale documento plastico appartenente verosimilmente a una statua acrolitica o a un’imponente figura togata o eroica, forse destinata a ornare uno degli spazi interni o porticati dell’antica Porticus Trisigmentata. Questa struttura, menzionata dalle fonti e localizzata nel settore nord-orientale del Foro, era caratterizzata da colonnati monolitici in marmo cipollino alti oltre undici metri, a sostegno di una sontuosa architettura absidata. La presenza della testa marmorea nei livelli di interro medievale – probabilmente rimaneggiati durante le spoliazioni sistematiche tra XIII e XV secolo – attesta non soltanto il riuso e la frammentazione delle testimonianze imperiali nel tessuto urbano successivo, ma anche il lento processo di accumulo e obliterazione che ha sigillato per secoli questo volto nel sottosuolo.
L’identità del personaggio raffigurato è, al momento, ancora oggetto di studio. Il volto maschile si caratterizza per una capigliatura folta, resa con una resa plastica intensa, e un’espressione concentrata, quasi ieratica. Non si esclude che possa trattarsi di un imperatore, forse lo stesso Traiano, la cui iconografia ufficiale si diffonde in numerosi contesti dell’Urbe e delle province, ma gli archeologi mantengono per ora un doveroso riserbo, in attesa di una più precisa comparazione stilistica e tipologica con i ritratti ufficiali noti.
La collocazione stratigrafica del ritrovamento è particolarmente interessante. Il reperto proviene da uno strato tardo-medievale di riempimento, ricco di materiali disomogenei, che testimonierebbero un utilizzo residuale dell’area a partire dall’alto medioevo. Ciò conferma una dinamica già ben attestata in altre parti del Foro: la monumentalità imperiale, una volta svuotata del suo significato politico originario, viene disarticolata, sepolta, in parte riutilizzata, e infine dimenticata. Ma mai perduta.
L’intervento di scavo, sostenuto dai fondi del PNRR, si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione dell’area dei Fori Imperiali e delle vie Alessandrina e Bonella, concepito per restituire al pubblico non soltanto la fruizione visiva dei resti monumentali, ma anche per riattivare la ricerca scientifica in un comparto archeologico già largamente indagato, ma ancora sorprendentemente generoso di testimonianze.
Come sottolineato dal sindaco Roberto Gualtieri, la scoperta “ci emoziona e ci lega al passato”, ma sarebbe più corretto dire che ci costringe a riconfigurare il modo stesso in cui intendiamo la persistenza del classico. Non si tratta soltanto di emozione – che pure ha un suo ruolo fondativo nell’immaginario collettivo – ma di confronto critico con la materialità del passato, con le sue frammentazioni, i suoi recuperi selettivi, le sue sopravvivenze.
È proprio in questa logica che va letta la riemersione della testa colossale: non come un feticcio isolato, ma come segmento di un sistema rappresentativo e simbolico che occupava il cuore politico dell’Urbe. L’arte imperiale romana, specie nel II secolo, si caratterizza per la capacità di fondere idealizzazione classica ed espressività concreta, ponendo i ritratti ufficiali in una tensione continua tra somiglianza e astrazione, tra riconoscibilità storica e dimensione sacrale. In tal senso, il volto appena riemerso dal sottosuolo appare come un ritorno dell’antico nel pieno della città contemporanea: un’irruzione non prevista, ma perfettamente coerente con il genius loci romano.
Infine, non può non colpire la capacità di Roma di farsi, ancora una volta, stratigrafia vivente. Ogni scavo, ogni ritrovamento, ogni lacerto di marmo restituito alla luce non è mai solo un oggetto, ma una soglia: attraverso di essa si accede non tanto a una storia remota e silente, quanto a un passato che parla, chiede ascolto e continua a plasmare la nostra identità. Roma, come sempre, non ci sorprende: ci interpella.