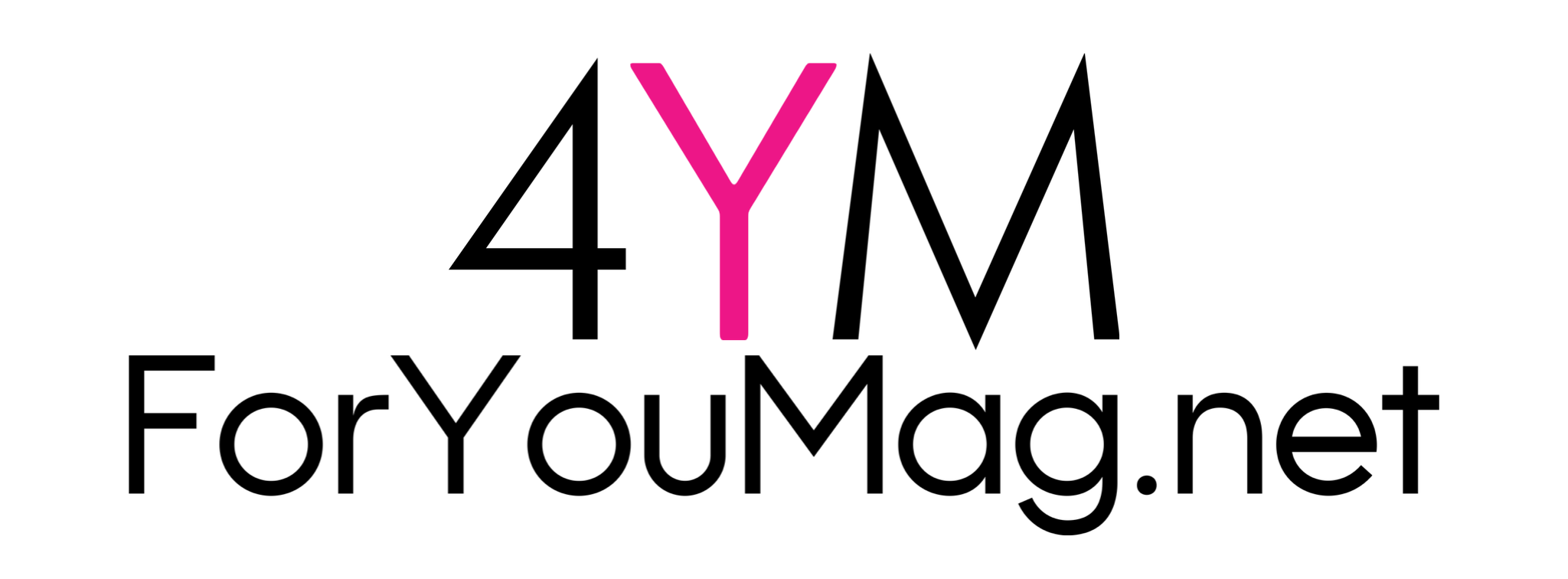Avviato un nuovo intervento conservativo sull’icona dell’arte etrusca. Studio, apertura al pubblico e mecenatismo si intrecciano in un progetto che coniuga conoscenza e responsabilità.
Nel cuore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il Sarcofago degli Sposi è tornato oggetto di studio e attenzione concreta. Non una celebrazione, ma l’inizio di un processo tecnico e scientifico che coinvolge istituzioni, restauratori e pubblico, attorno a una delle opere più emblematiche dell’Etruria arcaica. Quella che per molti è una delle immagini più riconoscibili dell’antichità italiana viene oggi sottoposta a un’azione di manutenzione e conoscenza che supera la mera conservazione: un lavoro analitico, sperimentale e condiviso.
Come tutte le cose che contano, il gesto è stato misurato, privo di clamore eppure colmo di densità. A prendere la parola sono state figure cardine dell’attuale politica museale e restaurativa italiana: Massimo Osanna, Luana Toniolo, Luigi Oliva, insieme a esponenti del mecenatismo culturale contemporaneo. Ma ancor prima delle parole, a parlare è stata l’opera stessa. Il Sarcofago degli Sposi, con la sua pelle d’argilla e il suo abbraccio perpetuo, ha nuovamente offerto il proprio corpo ferito alla cura, alla lettura, alla rinascita.
Il suo ritrovamento è uno di quegli eventi che scandiscono la memoria dell’archeologia come tappe di un poema epico. Era la seconda metà del XIX secolo. A Cerveteri, in località Banditaccia, nella tenuta del principe Ruspoli, emersero da uno scavo non guidato, ma mosso dalla brama del ritrovamento, centinaia di frammenti di terracotta dipinta. Non vi era, allora, una coscienza sistematica della stratigrafia: la scoperta era ancora dominata da un impulso avventuroso. Tuttavia, fu Felice Barnabei, figura visionaria, fondatore di Villa Giulia e protagonista del panorama culturale dell’Italia postunitaria, a intuire il valore di quel mucchio di “rottami fittili”. Per la somma di quattromila lire, strappò all’oblio quei cocci, riconoscendovi l’embrione di un capolavoro.
Ne derivò un restauro pionieristico che, grazie al lavoro degli artigiani e archeologi dell’epoca, restituì forma e coerenza a quella visione d’amore e morte: due sposi, semidistesi su una kline cerimoniale, raffigurati nell’eterno gesto del convivium. Lei con una mano alzata, lui con l’altro braccio ad accoglierla. Nessun pathos tragico, nessuna disperazione funeraria: solo una serena eternità domestica, che fa della tenerezza il proprio atto ultimo. Questo linguaggio plastico, profondamente etrusco e non più greco, ha dato origine a una delle immagini più forti della civiltà preromana.
Oggi, a distanza di oltre un secolo dal primo restauro e a più di cinquant’anni dall’ultima manutenzione, il Sarcofago è divenuto il centro di un nuovo processo conoscitivo. Il laboratorio di Villa Giulia è tornato a vivere: non più solo come contenitore di saperi, ma come corpo operante. L’Istituto Centrale per il Restauro ha avviato un intervento multidisciplinare volto non solo alla stabilità strutturale, ma anche alla decodifica dei materiali e delle tecniche originarie. L’intervento, in questa sua fase iniziale, si è concentrato sulla zona delle gambe dei due sposi, porzione apparentemente secondaria, ma centrale per il riequilibrio statico e per comprendere i sistemi d’assemblaggio delle terrecotte monumentali.
Ciò che rende il progetto singolare non è solo la qualità tecnica, ma anche la sua apertura: per due giorni alla settimana, il laboratorio è accessibile al pubblico. La cura del manufatto si fa così narrazione e pedagogia, azione visibile e trasparente, in cui restauratori, archeologi, storici dell’arte e specialisti dei materiali condividono il loro lavoro con la collettività. Una scelta che rompe il diaframma tra cantiere e museo, tra sapere e fruizione, restituendo alla cittadinanza l’intelligenza del gesto conservativo.
In questa operazione, il mecenatismo moderno ha giocato un ruolo centrale. Il contributo della Banca Popolare del Cassinate, attraverso lo strumento dell’Art Bonus, ha permesso la realizzazione di questo primo segmento d’intervento. Un gesto che riattualizza la tradizione antica del patronato artistico e culturale, trasferendone il senso civico alla contemporaneità. Il patrimonio culturale, in questa prospettiva, cessa di essere mera eredità da custodire e diventa responsabilità collettiva da rinnovare.
Nel dettaglio, l’intervento prevede una mappatura integrale dello stato di conservazione, l’analisi delle alterazioni, la verifica delle vecchie stuccature e integrazioni, l’applicazione di tecniche diagnostiche non invasive, come fluorescenza a raggi X e indagini multispettrali, oltre a modellazioni digitali tridimensionali. Lo scopo è quello di elaborare un piano sistemico di manutenzione programmata, che possa valere come modello per future esperienze su manufatti coevi.
La direttrice Luana Toniolo ha parlato con entusiasmo del progetto, sottolineandone il valore scientifico e didattico. Il direttore dell’ICR, Luigi Oliva, ha ribadito il significato epocale dell’intervento, sia per la complessità tecnica che per l’opportunità di sperimentare materiali compatibili con le superfici antiche. Massimo Osanna ha posto l’accento sulla nuova visione dei musei come centri vitali di ricerca e dialogo, più che meri contenitori.
Così, tra pietre, silenzi e nuove tecnologie, il Sarcofago degli Sposi è tornato a raccontarsi. Non più solo icona da osservare, ma corpo da curare, voce da ascoltare, racconto da attraversare. Non un monumento fermo nella polvere, ma un’opera ancora viva, chiamata a interagire con il presente e a trasmettere conoscenza. Un laboratorio di tempo e materia, aperto a chi vorrà ascoltarlo.
- archeologia italiana
- Art Bonus
- Arte Etrusca
- Banca Popolare del Cassinate
- Cerveteri
- conservazione beni culturali
- Davide Oliviero
- Felice Barnabei
- Istituto Centrale per il Restauro
- Luana Toniolo
- Luigi Oliva
- Massimo Osanna
- Mecenatismo culturale
- museo aperto
- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
- necropoli della Banditaccia
- patrimonio etrusco
- restauro archeologico
- Sarcofago degli Sposi
- storia dell’arte antica