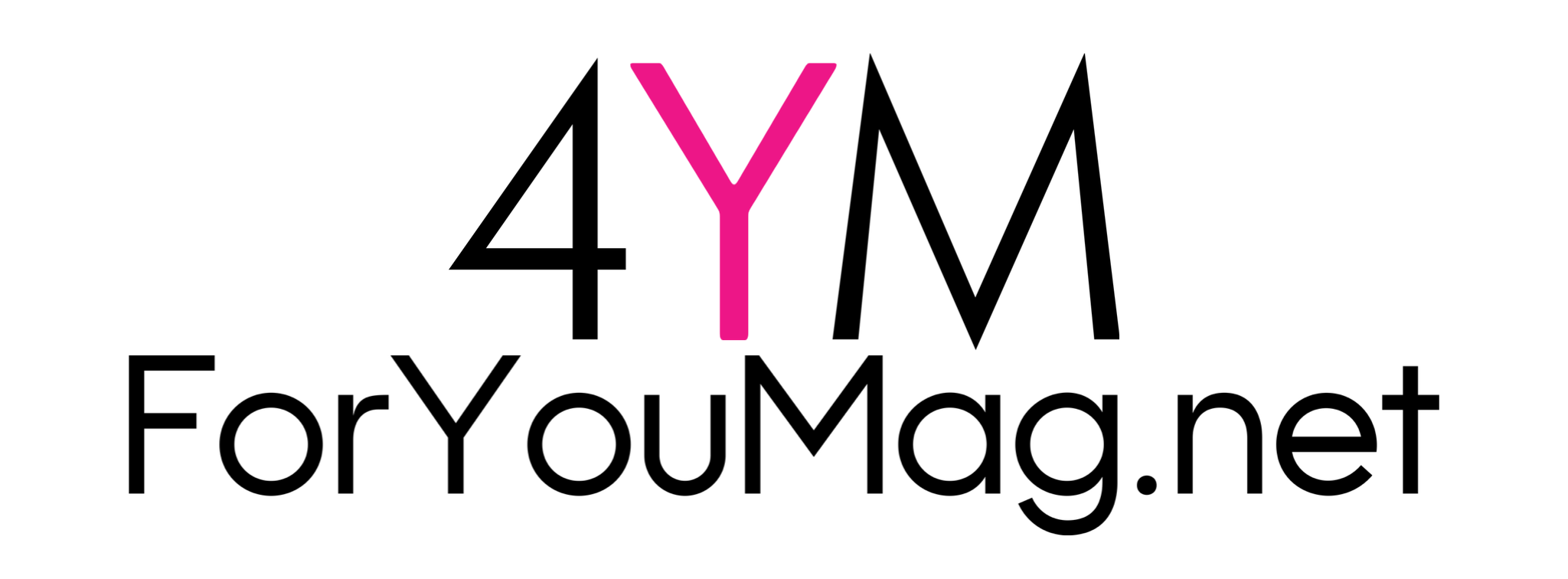Una barriera contro l’ineluttabile: il letto di traverso nella casa di Elle e Frisso testimonia l’estremo tentativo di salvezza degli abitanti di Pompei.
C’è un gesto, tra i tanti che la furia del Vesuvio ha sepolto sotto cumuli di cenere e lapilli, che oggi riemerge con un’eco simbolica tanto potente quanto struggente: un letto, ruotato di traverso, sbarrava la porta di una stanza. Non era lì per caso. Era una barriera, improvvisata ma voluta, contro l’inferno che avanzava. Nell’atto di opporre il proprio mobilio domestico al cataclisma naturale, gli abitanti della domus oggi chiamata “di Elle e Frisso” ci consegnano un frammento estremo di umanità. Un gesto quotidiano, disperato e umile, che si staglia contro l’inesorabile potenza del vulcano, come l’ultima diga contro la morte.
Il recente scavo lungo via del Vesuvio, all’interno del Parco Archeologico di Pompei, ha restituito una scena che ha del commovente e del rivelatore, come un lacerto di storia che, al pari di una reliquia laica, ci interroga sul senso della vita, della morte, e del tempo. La casa, così denominata per l’affresco mitologico che raffigura Elle e Frisso sul montone d’oro, era situata poco lontano dalla celebre Casa di Leda e il Cigno, già oggetto di scavo nel 2018. L’area è stata interessata da una complessa operazione di messa in sicurezza e consolidamento, il cui esito ha riportato alla luce ambienti di raffinata eleganza: un atrio con impluvium, un triclinium dalle pareti vivacemente decorate, una camera da letto, un vano coperto con apertura centrale da cui la pioggia, e purtroppo anche la pioggia di pietra, poteva penetrare.
Ed è proprio quest’ultima apertura a rappresentare forse il varco da cui i lapilli si insinuarono, come proiettili silenziosi, all’interno della casa. A fronte di tale minaccia, qualcuno — forse un capofamiglia, forse una madre — ha cercato rifugio in uno degli ambienti più interni, chiudendone l’accesso con un letto. Quel letto, oggi trasformato in calco grazie alla tecnica del gesso versato nei vuoti lasciati dal legno decomposto, è la memoria fossilizzata di un’azione consapevole, tragica e quasi teatrale. È la traccia materiale di un dramma silenzioso. È un monumento al gesto.

Non è l’unico segno della vita infranta tra quelle mura. I resti di almeno quattro individui, tra cui un bambino, sono stati rinvenuti accovacciati, accasciati, forse addormentati per sempre in quell’istante in cui la corrente piroclastica cancellò ogni respiro. Accanto a loro, un piccolo amuleto in bronzo: una bulla, che si metteva al collo dei fanciulli maschi fino alla pubertà. Un oggetto piccolo, ma denso di affetto e protezione simbolica, ora testimone muta della morte. Più in là, un sottoscala stipato di anfore — alcune contenenti garum, la celebre salsa di pesce — e un set da banchetto in bronzo: attingitoi, brocche, coppe. Tutto concorre a raccontare un’abitazione viva, abitata, amata.
Eppure, qualcosa in questa casa suggerisce l’interruzione, la sospensione, quasi un cantiere aperto: soglie rimosse, murature tagliate, lacune nelle decorazioni. Forse la casa era in fase di ristrutturazione. Forse i proprietari avevano appena avviato lavori di ammodernamento, come tanti altri a Pompei in quel periodo di relativa prosperità urbana. Ma l’eruzione sopraggiunse, improvvisa come un colpo di teatro, mentre il sipario era ancora aperto, lasciando le cose a metà. Quella sospensione, quella incompiutezza che si coglie nei dettagli, si fa emblema stesso della città di Pompei: un organismo vivo, trafitto nel cuore da una morte fulminea, eppure per sempre cristallizzato in un eterno presente.

Lo afferma con limpida lucidità Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco, che ricorda come scavare a Pompei significhi confrontarsi con la bellezza, sì, ma anche con la precarietà della condizione umana. Bellezza e morte: la dialettica perenne della nostra civiltà. A Pompei, ogni angolo racconta una scelta: quella di restare o di fuggire, di proteggere i propri cari, di affidarsi agli dei, al caso, alla ragione. E la domus di Elle e Frisso diventa in questo senso un teatro domestico, dove il mito e la cronaca si fondono.
Il mito, appunto. Sulla parete del triclinio, il pannello che dà il nome alla casa raffigura la tragedia di Elle, che precipita in mare mentre il fratello Frisso fugge sul montone dal vello d’oro. Una storia di salvezza parziale, come tante. Una mano tesa che non riesce a stringere l’altra. Il Mediterraneo, già allora, teatro di naufragi e promesse. Questo mito, nel I secolo d.C., non aveva più la valenza cultuale degli albori: era ornamento colto, narrazione visiva per intrattenere, istruire, sedurre. Ma qui, in questo contesto tragico, assume un valore aggiunto, quasi un presentimento. È come se la parete avesse voluto avvertire chi entrava: la salvezza è sempre un’illusione a metà.

Pompei continua a parlarci con voce limpida, anche se flebile come un soffio tra le rovine. E ci interroga non soltanto sul passato, ma sul nostro presente: sulla fragilità delle nostre certezze, sull’illusione del progresso, sul valore delle piccole cose — un letto, una bulla, una coppa di bronzo. E, soprattutto, sulla memoria. Perché in quel letto messo di traverso non c’è solo l’eco di un gesto antico: c’è la testimonianza di ciò che siamo, quando la vita ci chiede di decidere in un attimo, e l’eternità ci guarda.