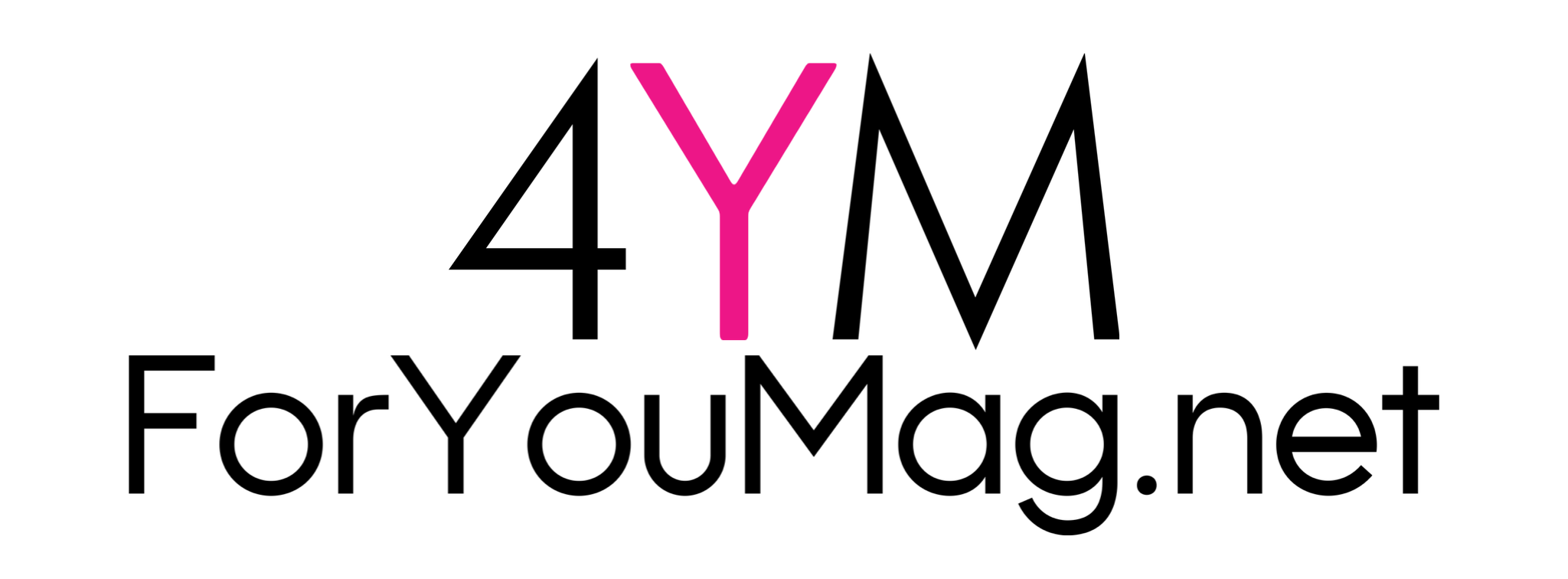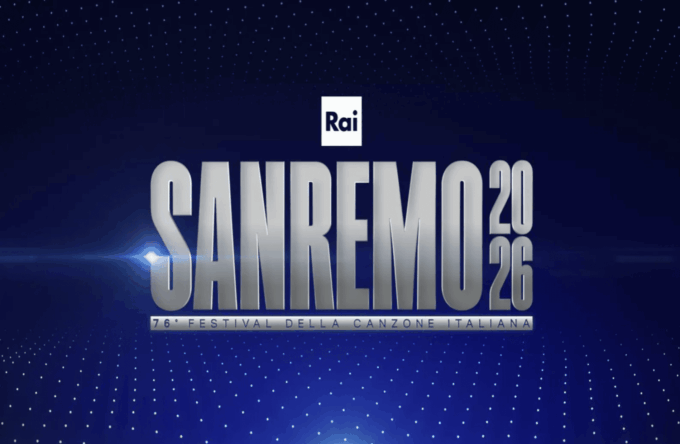Con oltre 750 partecipanti da tutto il mondo, la 19ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, curata da Carlo Ratti, si interroga sul futuro del progetto, intrecciando natura, tecnologia e visione collettiva in un percorso denso, immersivo e radicalmente umano
“L’architettura è sopravvivenza” – questa non è una dichiarazione, ma una condizione. E la Biennale Architettura 2025 di Venezia, curata da Carlo Ratti, ne fa la propria chiave di lettura. Intitolata Intelligens. Natural. Artificial. Collective, la 19ª Mostra Internazionale si propone non come esposizione, ma come sistema vivo: un organismo sensibile al tempo, capace di adattarsi, incorporare, resistere e, quando serve, sparire per lasciare spazio al futuro.
Distribuita tra gli spazi storici dell’Arsenale, i Giardini e numerosi palazzi della città, la Biennale 2025 affronta la crisi della forma architettonica come si affronta una deriva: con il peso della tecnica e la leggerezza del pensiero. L’architettura qui non si celebra; si interroga, si mette in discussione, si riconfigura nel suo rapporto con l’umano e con il mondo.

Il percorso si apre con Natural Intelligence, una sezione che non teme la radicalità. Le stanze diventano camere climatiche, dove si sperimenta la pressione atmosferica dell’Antropocene. L’installazione di Sonia Seneviratne e David Bresch — realizzata con la Fondazione Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto — impone al visitatore il respiro affannoso di un pianeta in disequilibrio. Non è retorica ecologista, ma progetto sensoriale: la temperatura sale, l’umidità aumenta, l’aria si fa densa come nei giorni in cui il futuro sembra un peso e non una promessa.
In una delle navate dell’Arsenale, l’architetto Kengo Kuma, in collaborazione con l’Università di Tokyo, presenta Living Structure: una serie di dispositivi animati che rielaborano in tempo reale la forma del legno, grazie a micro-innesti di intelligenza artificiale. Non è tecnologia che imita la natura, ma natura che accoglie la tecnologia per diventare altro. Una simbiosi — silenziosa, ironica, inevitabile — tra carbonio organico e codice binario.
Il corpo della Biennale, però, si definisce più per la sua coralità che per i suoi picchi: 750 partecipanti, tra architetti, filosofi, climatologi, agricoltori, programmatori, artisti e urbanisti. Ogni sezione è costruita come un cantiere di linguaggi e di possibilità. Non c’è l’ossessione del capolavoro, ma la costruzione continua di un pensiero plurale. Accanto ai pannelli esplicativi, sintetici e incisivi, compaiono anche i cosiddetti “riassunti AI”: cinque righe generate da intelligenze artificiali, accessibili a tutti e capaci di suggerire un nuovo modo di fruire l’architettura. Una visita, dunque, a ritmo variabile: chi desidera può addentrarsi, approfondire, decifrare; chi ha poco tempo può cogliere un’intuizione e portarsela via.
Tra le sorprese più affascinanti, l’intervento firmato da Patricia Urquiola: The Other Side of the Hill affronta il tema del declino demografico con un linguaggio di materia e memoria, evocando la montagna come simbolo della resistenza all’oblio. L’installazione, sospesa tra le trame di un paesaggio interiore e il segno di una mappa in estinzione, si impone come riflessione poetica sulla soglia tra sparizione e cura.
L’ambito Artificial Intelligence si apre invece con una provocazione: il reattore nucleare raffreddato a piombo liquido di Newcleo, disegnato da Pininfarina e realizzato con Fincantieri. L’architettura dell’invisibile, del potenziale, dell’energia. Ma anche del rischio. Una sfida tra etica e ingegneria, tra ottimismo tecnologico e timore ancestrale.

Poi, nel padiglione Out, l’esperienza si fa pura astrazione: il musicista Jean-Michel Jarre invita i visitatori a chiudere gli occhi e a lasciarsi guidare da un paesaggio sonoro che sostituisce la pianta con la vibrazione. Qui, la forma si dissolve e il progetto architettonico diventa pura orchestrazione di frequenze: una città acustica, senza geometria, senza materia, ma densissima di senso.
Eppure, il cuore pulsante della Biennale è nei padiglioni nazionali. Sessantasei in tutto, disseminati tra Giardini, Arsenale e spazi indipendenti della città. Un atlante disomogeneo, come ogni geografia autentica.
Nel Padiglione Vaticano, il progetto Opera Aperta si fa architettura del gesto. Il complesso di Santa Maria Ausiliatrice, nel sestiere di Castello, è trasformato in un cantiere partecipato: qui si restaura davvero, si lavora, si suona. Giovani musicisti possono accedere a una sala prove gratuita, la caffetteria e la mensa accolgono senza orari. L’architettura non come monumento, ma come relazione.

Il Padiglione Italia, curato da Guendalina Salimei, è un inno alle coste e alle acque. Terrae Aquae si sviluppa tra video d’archivio dell’Istituto Luce, fotografie immersive e sedute modulari che trasformano il giardino delle Tese delle Vergini in un approdo. Un padiglione che si può scalare, osservare dall’alto, come una terra in attesa di essere abitata da nuovi sensi.
Il Padiglione del Regno Unito, in collaborazione con il Kenya, propone Geology of Britannic Repair: un’analisi visiva e tattile sulla necessità di riparare, risarcire, riallacciare. Architettura come atto politico e materiale, come gesto riparatore nei confronti del suolo, della storia, dei silenzi.
Negli spazi del Padiglione USA, Porch: an architecture of generosity rilegge il concetto di porticato come spazio di prossimità, soglia, socialità. Modellini che sembrano miniature domestiche eppure sprigionano una visione globale: l’architettura come infrastruttura relazionale, soprattutto nei tempi incerti della democrazia.

Infine, il Giappone risponde con una lezione di equilibrio: In-Between, curato da Ju Aoki, esplora il concetto di “ma”, l’intervallo significativo tra le cose. In un padiglione rinnovato e a impatto zero, su due livelli, il visitatore è invitato a percepire lo spazio tra i pieni, tra i vuoti, tra i pensieri. È un’architettura che non si impone, ma suggerisce. Non dice: indica.
In conclusione, la Biennale 2025 è un laboratorio più che una vetrina. Non insegna, ma disegna domande. Architettura come forma di sopravvivenza, sì — ma anche come spazio della cura, come esercizio di ascolto, come disegno di futuro. L’edificio, la città, il pianeta: tutto è interconnesso. E chi costruisce, oggi, lo fa con la consapevolezza di essere parte di un’intelligenza collettiva — fatta di algoritmi e resine, di vento e di voci.
L’architettura, qui, non si guarda. Si attraversa. Si respira. E forse, si ricorda. Non per la sua forma, ma per quello che ci costringe a vedere di noi stessi.
- architettura contemporanea
- architettura e intelligenza artificiale
- Arsenale di Venezia
- Biennale Architettura Venezia 2025
- Carlo Ratti
- Davide Oliviero
- Giardini della Biennale
- Guendalina Salimei
- installazioni immersive
- Intelligens Natural Artificial Collective
- Jean-Michel Jarre
- Kengo Kuma
- Michelangelo Pistoletto
- Padiglione Italia
- Roma
- sostenibilità urbana
- urbanistica