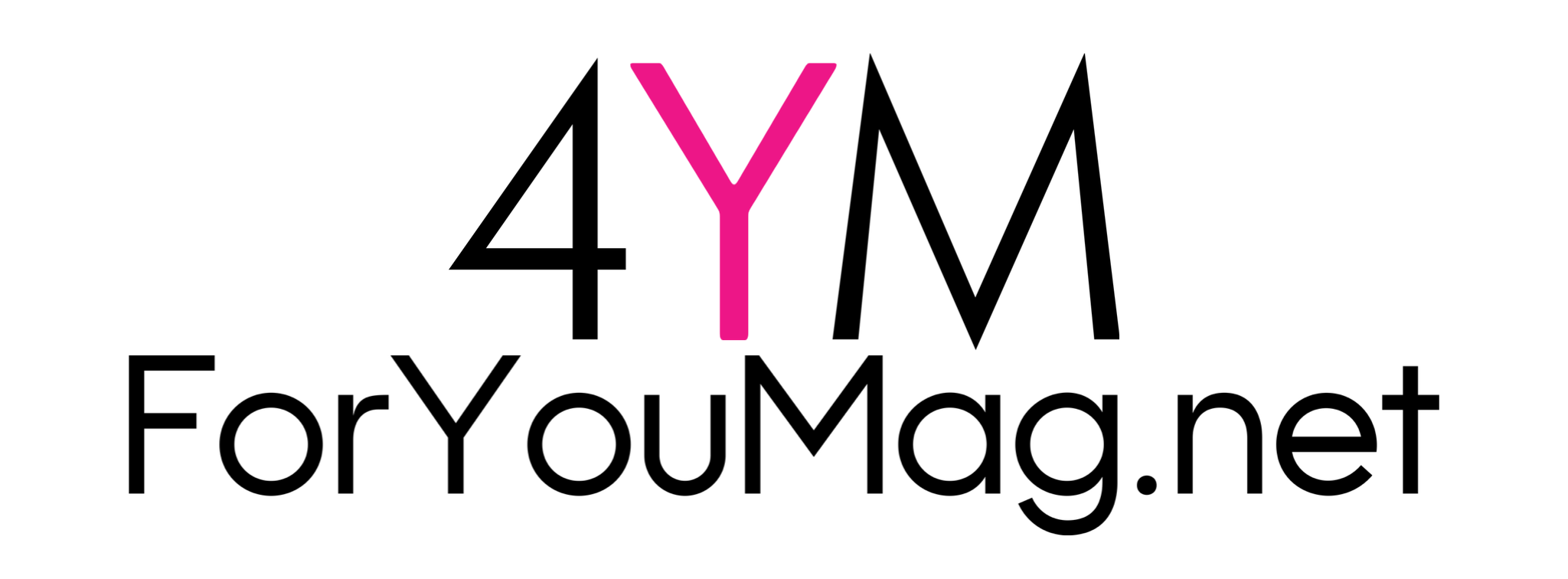“The past is never dead. It’s not even past.”
— William Faulkner, Requiem for a Nun (1951)
Un tempo esisteva un quartiere nel cuore di Roma, stretto tra il Tevere e le curve del Rione Sant’Angelo, che non si può più vedere ma si può ancora ricordare. Oggi, quella topografia obliterata torna a materializzarsi in forma esperienziale grazie a Bené Romì – Figli di Roma, un progetto presentato al Museo Ebraico di Roma che impiega la realtà aumentata per far emergere, tra le maglie della città contemporanea, i resti immateriali dell’antico Ghetto ebraico. L’iniziativa non è solo un esercizio tecnologico: è un atto politico, culturale, simbolico. Un modo per restituire parola e visibilità a uno spazio che è stato ridotto al silenzio, ma che non ha mai cessato di esistere nella memoria collettiva.
Realizzato con la collaborazione di Sagitek, Gsnet Italia e la Comunità Ebraica di Roma, Bené Romì si struttura come una drammaturgia urbana interattiva, un cammino che si sovrappone alla geografia della città di oggi per restituire quella di ieri. Il titolo del progetto, che in ebraico significa “Figli di Roma”, non è casuale: afferma una continuità storica che precede l’Impero stesso e resiste ai secoli, ai decreti papali, alle demolizioni del Novecento. Non si tratta di un’evocazione sentimentale, ma di una riaffermazione di identità: i Bené Romì non sono ospiti, ma costituenti. La loro storia non è una nota a piè di pagina, ma un capitolo centrale dell’identità romana.
Il cuore tecnologico dell’installazione è l’impiego di visori immersivi e dispositivi mobili che permettono ai visitatori di percorrere fisicamente la città mentre la attraversano anche nel tempo. Grazie a un sistema di geolocalizzazione e alla sovrapposizione di mappe digitali, la Roma attuale si trasforma in palinsesto: sotto la pietra liscia del Lungotevere e i marciapiedi turistici emergono le strade strette, le abitazioni affastellate, le sinagoghe e le botteghe del Seicento. Il quartiere demolito dopo l’Unità d’Italia, e rimosso dal tessuto urbano per far posto alla “modernità”, torna a vivere nella sua densità percettiva.

Ma Bené Romì non si limita a una ricostruzione architettonica. Ogni tappa del percorso – cinque in tutto – è punteggiata da suoni d’ambiente, voci tratte da fonti d’archivio, citazioni letterarie e narrazioni sonore che restituiscono la quotidianità del Ghetto: le chiusure notturne dei cancelli dopo la bolla Cum nimis absurdum del 1555, le famiglie stipate in spazi angusti, i mestieri tramandati, le scuole rabbiniche, le confraternite caritatevoli, le discussioni dottrinali, le preghiere e le ricorrenze. Questo ambiente virtuale non ricostruisce soltanto uno spazio: rievoca un tempo, con la sua densità simbolica, con la sua pluralità di storie.
Il Ghetto ebraico romano, come emerge con forza dal progetto, non fu solo luogo di costrizione e marginalizzazione. Fu anche, e forse soprattutto, un laboratorio di resistenza culturale. Nelle sue mura si è articolata per secoli una forma di socialità autonoma, in cui l’imposizione esterna ha generato strutture interne di coesione: un sistema educativo parallelo, una liturgia propria, un patrimonio linguistico che conserva tuttora tracce di giudeo-romanesco. Le Cinque Scole – sinagoghe distinte ma riunite sotto un unico tetto nel XIX secolo – erano più che luoghi di culto: erano nodi simbolici, roccaforti identitarie, custodi di una memoria trasmessa anche quando la libertà era assente.
L’approccio scelto da Bené Romì è esplicitamente critico. Il Ghetto non viene romanticizzato, né spettacolarizzato. La realtà aumentata non è un fine, ma uno strumento per interrogare la storia e le sue rimozioni. Il progetto rifiuta l’estetizzazione nostalgica e punta invece su una restituzione problematica, fatta di tensioni, conflitti, contraddizioni. Si rivendica la stratificazione: la compresenza di povertà e creatività, di emarginazione e orgoglio, di umiliazione e dignità. Il risultato è un’immersione che coinvolge il corpo e la coscienza, e che restituisce dignità all’esperienza degli esclusi.
Il quartiere del Ghetto, oggi trasformato in meta turistica e sede di ristoranti kasher, librerie e itinerari guidati, viene qui decostruito nella sua dimensione commerciale per essere riletto come zona di frizione, di sedimentazione, di tensione identitaria. La memoria, in questa prospettiva, non è un dato, ma un processo. E la tecnologia, anziché sostituire l’autenticità, ne diventa mediatrice, proprio perché permette di attivare percorsi conoscitivi che attraversano sensorialità e coscienza storica.
Percorrere il Ghetto ricostruito in realtà aumentata significa abitare una soglia: tra il visibile e l’invisibile, tra ciò che è stato cancellato e ciò che si ostina a restare. L’esperienza non è puramente estetica, ma conoscitiva. Camminare tra le rovine invisibili di un quartiere scomparso equivale ad ascoltare ciò che la pietra non dice ma ricorda. In questo senso, Bené Romì non è solo un’installazione museale, ma una forma di pedagogia civile. Un modo per dire che nessuna città può veramente comprendere se stessa se non attraversa anche i suoi traumi.

Il Museo Ebraico di Roma, promotore dell’iniziativa, conferma con questo progetto il proprio ruolo di istituzione culturale attiva e responsabile. Non più solo spazio di conservazione, ma agente nella produzione critica di memoria. Da anni impegnato in percorsi educativi, il Museo si fa qui promotore di una narrazione che non si accontenta di trasmettere il passato, ma lo interroga, lo rende fruibile, lo mette in relazione con il presente. La memoria diventa così una pratica: una grammatica mobile da esercitare, non un atlante da consultare.
L’accessibilità è un altro punto di forza del progetto. Oltre all’installazione permanente presso il museo, sono previste versioni itineranti da proporre in contesti scolastici, festival, istituzioni culturali internazionali. Il Ghetto, dunque, non viene recluso nella sua localizzazione storica, ma diventa paradigma: esempio di come la memoria di uno spazio marginale possa generare nuove forme di cittadinanza, nuovi linguaggi museali, nuovi strumenti educativi. La sua virtualizzazione ne consente la disseminazione, la sua assenza fisica ne rende più forte la presenza simbolica.
Nella Roma delle stratificazioni infinite, il Ghetto è un livello nascosto che Bené Romì ci invita a riscoprire. Non un’assenza, ma un nodo. Non un vuoto, ma un’intermittenza di memoria. E forse il senso più profondo del progetto è proprio questo: ricordarci che le città sono fatte di ciò che si vede, ma anche di ciò che si sceglie di non vedere. E che ogni forma di conoscenza autentica comincia dall’attraversare l’invisibile.